La musica nascosta dell’Universo
La mia vita a caccia delle onde gravitazionali
Adalberto Giazotto
A cura di Andrea Parlangeli
Einaudi, 2018
Questo, per l’Einaudi, credo sia un libro davvero particolare.
Appare tale già a un attento esame del suo aspetto esterno: esibisce infatti una veste grafica del tutto diversa dai canoni estetici, peraltro mai dichiarati, della nota casa editrice torinese.
Procedendo dall’alto, tra il nome dell’autore, il titolo, il sottotitolo, il nome del curatore, l’illustrazione, l’epigrafe e il marchio della famosa
collana Gli struzzi, nonostante il fondo bianco, sono convinto che a questa vada la palma di copertina più articolata di tutto il catalogo einaudiano.
L’illustrazione, poi, come spiegato nell’epigrafe di “taglio basso”, può di primo acchito far pensare a qualche tipo particolare di antenna a diapason, ma in realtà è la “U” di “Universo” colorata di arancione, all’interno della quale spiraleggia, un’onda bianca.
Il curatore del libro è il giornalista Andrea Parlangeli. Laureato in fisica, non a caso ci propone la lunga intervista rilasciatagli da Adalberto Giazotto (Genova, 1940 – Pisa, 2017), uno dei padri dell
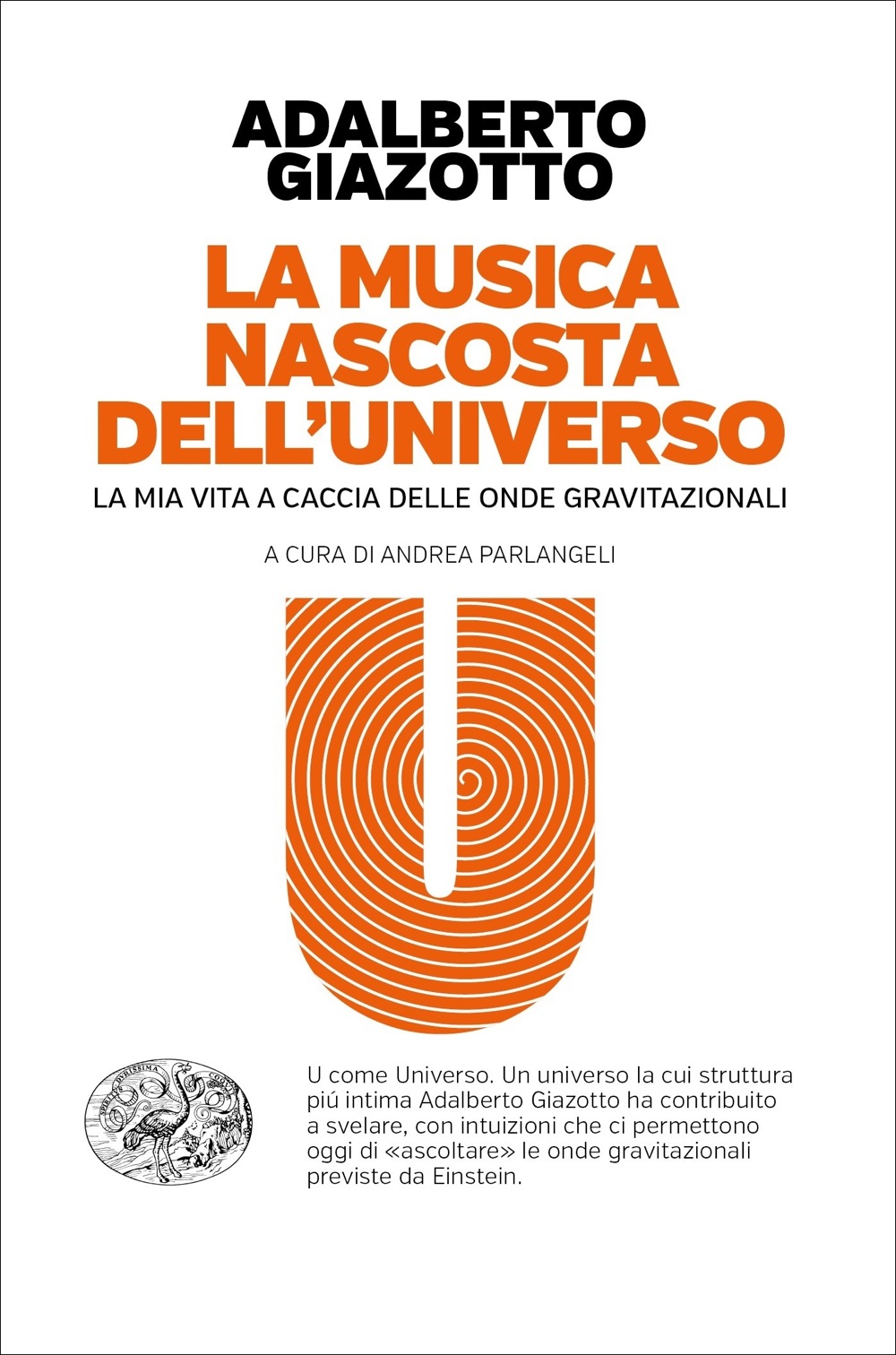
a ricerca delle onde gravitazionali.
Il testo è quindi un autoritratto che Parlangeli, già abituato a trattare simili opere1, immagino avrà solo ritoccato qui e là per rinforzare o scaricare alcune delle vivacissime pennellate di questo amarcord nel quale Giazotto riassume non solo la sua vicenda personale e professionale, ma pure un intero pezzo di storia della scienza italiana di cui è stato di sicuro protagonista.
Se la copertina si fa notare, non è da meno l’indice dove, forse a omaggiare il padre Remo Giazotto, not
o musicista e autore del completamento dell’Adagio (in origine incompiuto) di Albinoni, in corrispondenza dei vari capitoli troviamo diciture mutuate dalla terminologia musicale2. Già da questa scelta appare chiaro come la musica sia sempre stata una presenza costante in casa Giazotto, nonché un elemento fondamentale nella formazione del giovane Adalberto, educato all’ascolto del repertorio classico quotidianamente riprodotto dai dischi e dal pianoforte paterno.
Continuando la lettura del volume, non possiamo fare a meno di sospettare che la passione giovanile per l’elettronica applicata alla costruzione di radio e di impianti hi-fi non sia altro che il trade-union tra quella importante eredità artistica e la scelta di occuparsi professionalmente di strategie tecnologiche per rilevare le onde gravitazionali: la ricerca della pulizia del suono e il tentativo di captare, tramite antenne, i deboli segnali sonori in arrivo da lontano, sembrano proprio essere stati i semi dai quali si è propagata la passione per quella particolare branca dell’astrofisica che, come nel corso della narrazione viene ampiamente spiegato, dell’elettronica fa un ampio uso.
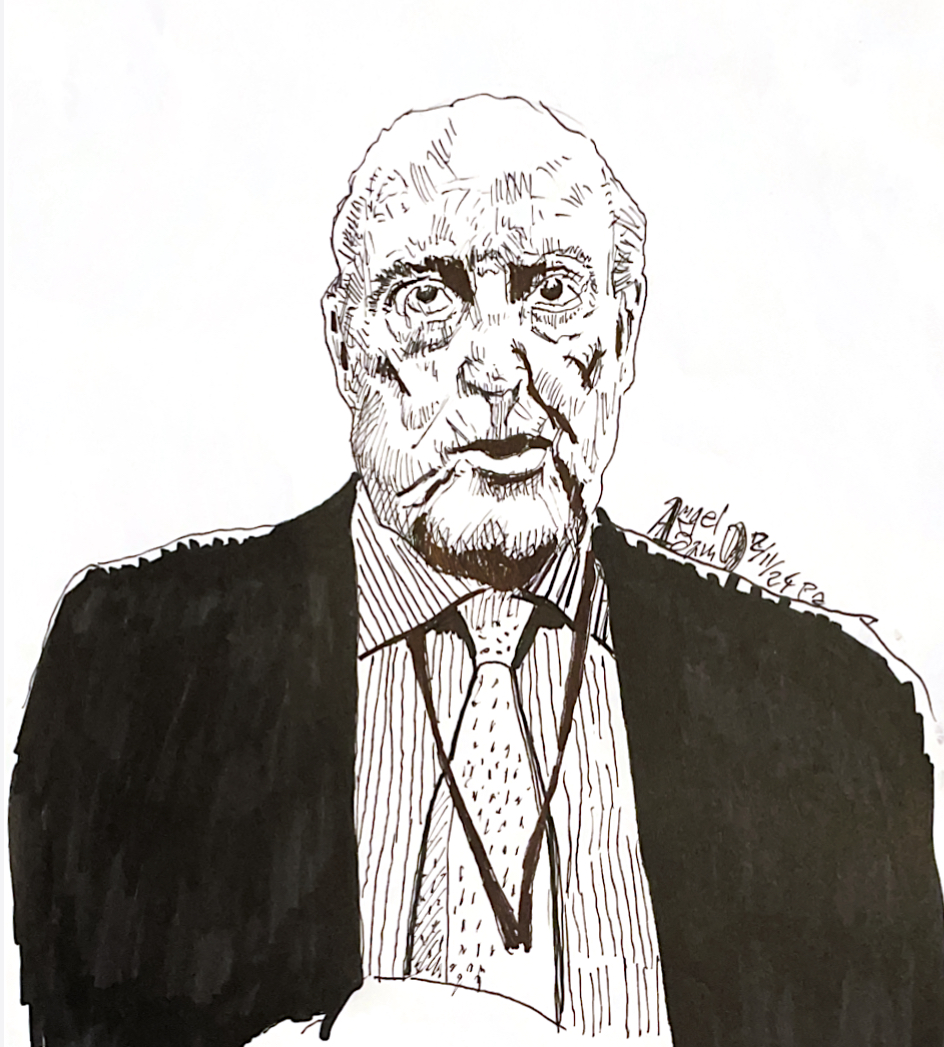 I dodici capitoli di cui il libro si compone mi sembrano dedicati ognuno a un argomento diverso: ad esempio il secondo, che si apre con la storia dell’annuncio della scoperta della prima onda gravitazionale, è di carattere musicale, e lo è anche nelle parole scelte per raccontare quell’evento. Il protagonista infatti inizia qui a parlare della necessità di “azzittire” qualsiasi “rumore” che potesse disturbare la ricezione di quell’onda sfuggita per cento anni all’”ascolto” degli scienziati; narra della costruzione delle “grandi orecchie” come Virgo (costruito proprio a partire da una sua idea e collocato a Cascina, vicino Pisa) – e LIGO – più avanti li paragona a “sofisticati microfoni” -, orecchie necessarie per “ascoltare la musica dell’universo: il cinguettio di due buchi neri, il canto regolare di una pulsar, l’acuto di una supernova, il lontano boato del Big Bang”; parla poi della sua esigenza di “leggere l’intero spartito”, specie le note gravi, della musica portata dalle onde gravitazionali.
I dodici capitoli di cui il libro si compone mi sembrano dedicati ognuno a un argomento diverso: ad esempio il secondo, che si apre con la storia dell’annuncio della scoperta della prima onda gravitazionale, è di carattere musicale, e lo è anche nelle parole scelte per raccontare quell’evento. Il protagonista infatti inizia qui a parlare della necessità di “azzittire” qualsiasi “rumore” che potesse disturbare la ricezione di quell’onda sfuggita per cento anni all’”ascolto” degli scienziati; narra della costruzione delle “grandi orecchie” come Virgo (costruito proprio a partire da una sua idea e collocato a Cascina, vicino Pisa) – e LIGO – più avanti li paragona a “sofisticati microfoni” -, orecchie necessarie per “ascoltare la musica dell’universo: il cinguettio di due buchi neri, il canto regolare di una pulsar, l’acuto di una supernova, il lontano boato del Big Bang”; parla poi della sua esigenza di “leggere l’intero spartito”, specie le note gravi, della musica portata dalle onde gravitazionali.
Qui ritorna ancora l’Adagio di Albinoni-Giazotto, e compare pure Beethoven a proposito del quale l’intervistato considera “É davvero incredibile che qualcuno sia riuscito a scrivere una musica con un tale livello di bellezza e di complessità, e che altri esseri umani come me riescano a comprenderla. Per me, la profondità e le trovate di Beethoven nella musica hanno un impatto equivalente alla relatività generale e alle altre cose di cui mi sono occupato per tutta la vita nel campo della fisica”.
Un’apologia della musica, quindi, ma anche della teoria della relatività cui invece dedica il capitolo successivo in apertura del quale troviamo l’affermazione: “Studiare la relatività è stata una delle esperienze più significative della mia vita. Questa teoria è una delle vette più alte mai raggiunte dal pensiero umano e trovo un peccato che in tanti la ignorino”. Qui, tra illuminanti spiegazioni (finanche del significato fisico delle equazioni di Maxwell), Giazotto racconta del primo affacciarsi dell’idea di onda gravitazionale negli scritti di Einstein, e di quei successivi tentennamenti di fronte alla sua stessa idea, capaci di restituirci un’idea molto umana del genio tedesco.
Il capitolo successivo, aperto da uno dei diversi, brevi e pacati racconti autobiografici, si rivela un interessante resoconto storico dei primi tentativi falliti di rivelare quel moto ondoso dello spazio-tempo usando barre metalliche. Nonostante i ripetuti tentativi (e molti falsi allarmi) di Joseph Weber, pioniere assoluto di quel genere di studi, con esse non verrà mai rilevato nulla e proprio per questo, usando ancora una volta un’idea musicale, Giazotto le definì “xilofoni muti”.
In Italia studi analoghi, e con stesso risultato, vennero condotti da Guido Pizzella e da Edoardo Amaldi il quale, poi, forse per primo comprenderà che il futuro della ricerca delle onde gravitazionali sarebbe stato scritto dagli interferometri, strumenti il cui funzionamento Giazotto descrive molto bene parlandone sia nel testo che in una opportuna appendice a fine libro.
Il resto del volume da qui in poi diventa un vero e proprio crescendo beethoveniano in cui la storia della passione teorica per la caccia a quelle onde così elusive da restare latitanti per un intero secolo, dovette trovare continui compromessi con le difficoltà tecnologiche incontrate per conquistare quel silenzio a la Cage così importante al fine di “sentire” solo le onde gravitazionali.
Esse, partite enormi chissà dove nel lontano buio cosmico, lungo il lunghissimo tragitto fin qui si attenuano fino a diventare increspature di dimensioni subatomiche del tessuto spazio-temporale così sottili da risultare rilevabili esclusivamente mediante l’uso di grandi interferometri che però faticano a distinguerle da altri “rumori” di origine sismica o antropica.
Per slegare quanto più possibile le sorti degli strumenti usati – essenzialmente potentissimi fasci laser e specchi – da quelle del mondo circostante, si capì che bisognava migliorare le tecniche criogeniche e la realizzazione del vuoto, ma si rese pure necessario sospendere la strumentazione usando particolari fili e ammortizzatori: dispositivi la cui “applicazione più concreta e tangibile, affascinante, straordinaria, di una macchina così complessa (…) è se stessa. O meglio, il miglioramento di sé (…)”, un periodo che mi fa riandare con la mente alle favolose macchine inutili di Bruno Munari: strani accrocchi nati negli stessi anni in cui a Cascina Giazotto ragionava col suo staff su come costruirne altri che invece che inutili, risultassero utilissimi nell’isolare i bracci dell’interferometro dal resto del mondo per permetterci di sentire, oggettivizzandolo, il suo stesso respiro ondoso.
“I sommersi e i salvati”
Con grande generosità, Giazotto cita i nomi di moltissimi suoi compagni di avventura e c’è spazio pure per meteore che, avendo a volte toccato la sua vicenda solo tangenzialmente, gli hanno lasciato un’idea, uno spunto, un indizio. Salva quindi molti colleghi dall’oblio cui la maggior parte dei ricercatori sono di solito destinati – per inciso, anche lui, come Ferrini, cita Marco Drago, il primo ricercatore ad aver notato l’arrivo della prima onda gravitazionale -, e nel settimo capitolo, oltre a quei nomi, emergono pure temi che restituiscono un quadro molto realistico e sincero delle dinamiche sociologiche, ambientalistiche, politiche e finanche architettoniche che un progetto di grande portata come la costruzione di Virgo ha messo in moto.
Il tono di “La musica nascosta dell’Universo” è di sicuro trionfale e, dal momento che sia l’interferometro americano LIGO che quello italiano Virgo concepito dallo stesso Giazotto, hanno rilevato le prime due onde gravitazionali, non potrebbe essere altrimenti; ma lo è in una maniera pacata, elegante: davanti a Parlangeli, Giazotto non sbraga, non sbrodola, non esagera (forse Maraini aggiungerebbe “non vaterca, né gluisce e molto raramente barigatta”3), e nel corso della lettura c’è spesso spazio per pagine caratterizzate da una grande e intima delicatezza che fanno apparire questo personaggio a rilievo rispetto ad altri ritratti presenti in pubblicazioni simili del passato4.
Un fattore credo degno di nota è una certa tendenza, tutta contemporanea, all’autobiografia scientifica. Nulla di male in tutto ciò, anzi! Si tratta di un dato che mi induce a sospettare come giunto a conclusione quel processo di trasformazione dell’ambiente della ricerca che, inizialmente composto da scienziati rinserrati nelle loro turris eburnee, oggi li vede partecipi della vita pubblica in internet, in televisione, su riviste, quotidiani e libri.
Insomma, come si diceva, un libro molto particolare, ma anche elegante e sussurrato come lo è un’onda che qui si va oramai spegnendo, e nel quale la giusta felicità di Giazotto per essere riuscito a vedere, dopo una vita dedicata a questa ricerca, la prima e la seconda onda gravitazionale, si traduce in una gioia smisurata, ma sempre dominata, che, per continuare la metafora musicale, si accorda perfettamente con un umile invito a carpire alla Natura i suoi misteri più belli e nascosti.
Angelo Adamo
[1] Dopo avere intervistato Guido Tonelli, Parlangeli ha pure suggerito e curato la scrittura del libro La nascita imperfetta delle cose, volume nel quale si narra di come al CERN è stato scoperto il bosone di Higgs.
[2] Introduzione: Preludio; Cap. I: Adagio affettuoso e appassionato; Cap. II: Allegretto; Cap. III: Andante con variazioni; Cap. IV: Adagio sostenuto, Cap. V: Presto con fuoco; Cap. VI: Allegro assai; Cap. VII: Presto alla tedesca; Cap. VIII: Largo-Allegro; Cap. IX: Vivace ma non troppo; Cap. X: Moderato cantabile molto espressivo; Cap. XI: Maestoso – Allegro con brio e appassionato; Cap. XII: Arietta: Adagio molto semplice e cantabile.
Comunque “conosco” almeno un altro libro pubblicato da un astrofisico che, volendo omaggiare la musica, sfrutta la stessa terminologia per i vari capitoli e paragrafi. Si tratta del mio Pianeti tra le note. Appunti di un astronomo divulgatore, Collana iBlu, Springer, Milano, 2009 (https://www.amazon.it/Pianeti-note-Appunti-astronomo-divulgatore/dp/8847011841)
[3] Versi tratti da Il lonfo, componimento più famoso della raccolta di testi metasemantici La gnosi delle fanfole di Fosco Maraini, opera ripubblicata di recente da La Nave di Teseo.
[4] Ne parlavo in una recensione di qualche tempo fa: ehttps://www.media.inaf.it/2021/07/14/lettere-dalla-fine-del-mondo/

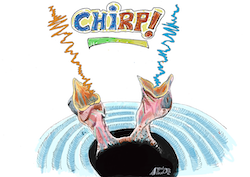
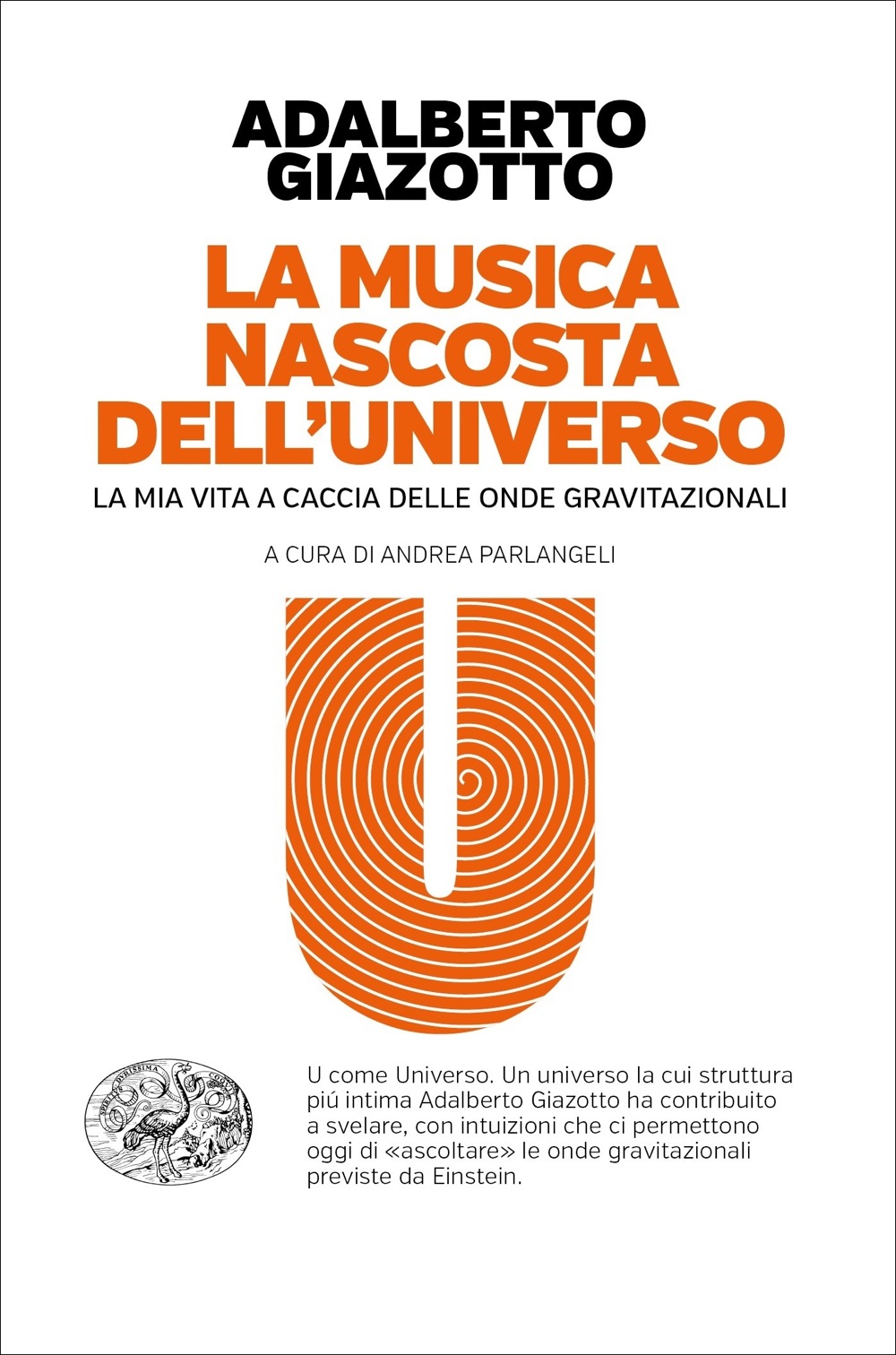
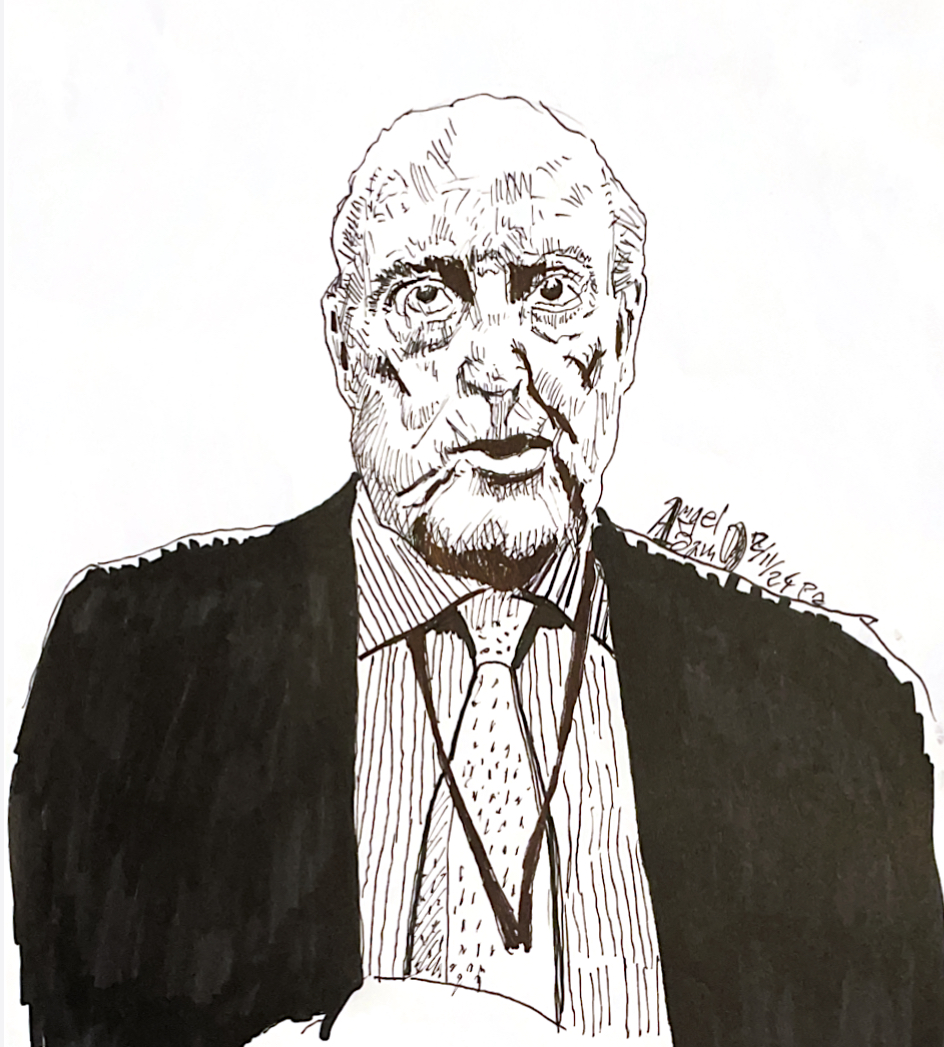 I dodici capitoli di cui il libro si compone mi sembrano dedicati ognuno a un argomento diverso: ad esempio il secondo, che si apre con la storia dell’annuncio della
I dodici capitoli di cui il libro si compone mi sembrano dedicati ognuno a un argomento diverso: ad esempio il secondo, che si apre con la storia dell’annuncio della 
